Dove nasce
Il territorio
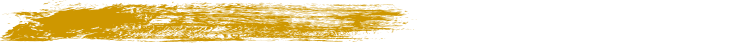
In Abruzzo l'olivicoltura ha origine antichissime. Le prime testimonianze risalgano al V secolo AC, con Virgilio che documenta la presenza dell'olivo nella Marsica "dove vegetava rigoglioso lungo le sponde del lago Fucino".
Nel paesaggio abruzzese l'olivo ha da sempre rappresentato un importante valore identitario e caratteristico; la sua particolare vocazione olivicola e olearia affonda le sue autentiche radici nell'aspro e incontaminato territorio rurale, dalle pendici del Gran Sasso, al litorale Adriatico, dalle preziose colline teatine alle valli della Majella.
Le favorevoli condizioni pedoclimatiche, in particolare nell'esteso territorio di Bucchianico, fanno si che la pianta dell'olivo prosperi sui suoi colli che svettano sul mare Adriatico e, cullata dalla montagna madre Majella, fino ai margini dei centri abitati.
Le varietà dei nostri ulivi
Lo sapevi che...
Per la civiltà greca la pianta dell'olivo era sacra agli Dei, chi osava reciderlo o estirparlo era punito con l'esilio o addirittura la morte.
I Romani furono i primi a classificare l'olio in base alla qualità delle olive e della loro lavorazione e quindi grado di purezza.
Presso i popoli fenici e cretesi l'olio aveva funzioni iniziatiche ed era soprattutto fonte di luce, non solo in senso metaforico: furono i Fenici a diffondere l'uso della lucerna.
Omero, nell'Odissea, racconta dell'offerta che la dea Atena fece ad Ulisse: una fiala di olio d'oliva, attraverso la quale l'eroe riacquistò forza e bellezza. Plinio il Vecchio dedicò invece un intero capitolo della sua Naturalis historia all'olivo e alle sue proprietà virtuose (Cap. XVII).
Il nostro attuale olio extra vergine di oliva in epoca romana sarebbe chiamato oleum ex albis ulivis, il più pregiato.
























